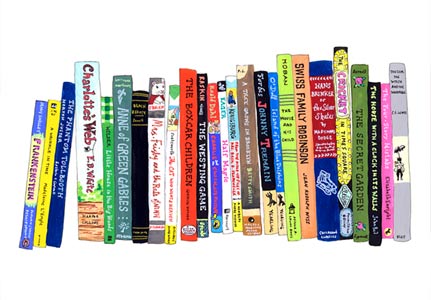Giosuè
Carducci
La
vita
Nacque
nel 1835 a Val di Castello , in Versilia, da famiglia medio borghese. Trascorse
l'infanzia in Maremma, tra Bolgheri e Castagneto. Studiò alla scuola Normale
Superiore di Pisa, laureandosi in Lettere nel 1856. Insegnò quindi alla
cattedra di Bologna e partecipò intensamente alla vita culturale del tempo,
collaborando ai periodici culturali allori più prestigiosi, come il Fanfulla
della Domenica. Ottenne il premio Nobel per la poesia nel 1906 e morì l'anno
successivo.
L'evoluzione
ideologica e letteraria
- Carducci fu inizialmente di idee
accesamente democratiche e repubblicane. Negli anni giovanili seguì con
entusiasmo le vicende risorgimentali, in specie l'impresa garibaldina.
- Come molti democratici subì una grande
delusione alla conclusione del processo unitario con il trionfo del
compromesso monarchico delle forze della Destra storica. La sua attività
intellettuale e poetica si indirizzò alla polemica contro l'Italia vile
del suo tempo, che non rispondeva agli ideali risorgimentali.
- Si fece giacobinamente sostenitore dei
diritti del popolo , mitizzando la democratica del popolo come forza
motrice della storia, capace di abbattere le tirannidi e di trasformare il
mondo.
- Fu anticlericale e si scagliò contro lo
Chiesa ed il papa come baluardi della reazione tirannica. Polemizzò contro
la stessa religione cristiana, in nome della concezione di della vita
pagana e classica, libera da ogni ascetismo e presentò la religione come
un residuo dell'oscurantismo medievale.
- Esaltò il progresso
- Negli anni maturi, con la stabilizzazione
della situazione italiana dopo la presa di Roma, moderò le sue posizioni.
Si delineò una involuzione monarchica e conservatrice. Il suo acceso
patriottismo si colorò di nazionalismo.
- Si attenuò anche il suo anticlericalismo
ed assunse atteggiamenti concilianti verso il papa e riconobbe il valore
del cristianesimo.
- Negli anni giovanili assunse posizioni
violentemente antiromantiche , proclamandosi scudiero dei classici. In
particolare contestava il romanticismo sentimentale della seconda
generazione e si scagliava anche contro il romanticismo cristiano di
Manzoni.
- Cercando una forma adatta alla sua poesia
civile e battagliera, Carducci mirò alla restaurazione di un discorso
poetico alto, che ricuperasse la dignità aulica dei classici e per questo
disedegnò i generi popolari prediletti dai romantici
- Più avanti si ampliarono i suoi orizzonti
culturali e, con l'affievolrisi dell'impeto polemico, si sostituì in lui
un ripiegamento intimo, l'analisi di momenti di sconforto, di tedio
esistenziale.
- Compaiono anche tendenze evasive,
l'abbandono alla fantasticheria, l'impulso a fuggire dallo scuallore del
presente
L'immagine del poeta Carducci è quindi
caratterizzata da:
- L'immagine di un poeta sostanzialmente
tardo romantico, che si aggrappa ad un sogno di sanità classica e di
pagana solarità solo per esorcizzare le inquietudini e le angosce che lo
assillano, secondo una evasione di tipo esotizzante
- Manca tuttavia una profondità conoscitiva
nella malattia romantica del Carducci (appare banale e provincialmente
limitato)
- Il valore di Carducci è stato
ridimensionato e non è stato più catalogato fra i grandi
Le Rime nuove
Raccolta del 1887 di poesie. Le Rime Nuove
nascono da spunti intimi, privati o dalla sollecitazione della letteratura e
della storia. Sono accomunate dalle scelte metriche, che si rifanno alle forma
tradizionali della lirica italiana.
- Una cospicua parte di queste poesie è
ispirata dalla letteratura: nasce da impressioni di lettura e vuole
rendere le emozioni originate dalla bellezza artistica (liriche di Omero,
Virglio, Dante, Petrarca , Ariosto)
- Vi è un gruppo di poesie in cui si
esprima la volontà di fuga in un'Ellade antica, con la rievocazione della
propria infanzia e giovinezza
Odi barbare
Pubblicate nel 1877, in esse C. abbandona
i metri tradizionali italiani e cerca di riprodurre quelli classici. Queste
poesie presentano gli stessi motivi delle Rime Nuove ma vi si accentuano le
tendenze evasive, a rifugiarsi nel passato come paradiso perduto di bellezza e
di forza, per dimenticare il presente.
Rime e ritmi: le odi celebrative
Sono poesie altamente intonate, di una
eloquenza sonora, sono quelle del poeta vate dei destini della patria. In
questa ultima fase della lirica carducciana la critica ha rintracciato una vena
poetica nuova, più rarefatta e sfumata. E' una poesia già più vicina alla
lirica decadente (Pascoli e D'Annunzio).
Inno a Satana
Fu composto nel settembre 1863 e fu
pubblicato nel novembre 1865. Fonti: Michelet,
Quinet, Proudon
I temi dell'opera sono:
- Carducci stesso diede un giudizio molto
severo a questa sua opera definendola una 'chitarronata'. E' un
documento in realtà molto importante nel suo sistema di idee e di una
tendenza della cultura e della mentalità contemporanee.
- Mentre dai reazionari ogni aspetto della
modernità era condannato come prodotto di Satana, Carducci rovescia questa
concezione polemicamente in positivo, celebrando al figura di Satana. Le
cose che i reazionari esecrano come opera del demonio, per Carducci sono gli
aspetti più positivi della vita.
- Si compendia il trionfo del progresso,
nel simbolo della macchina, la locomotiva.
- Abbiamo una concezione contrapposta a
quella del cristianesimo , che per Carducci nega i beni del mondo, la
bellezza artistica, il progresso. Satana trionfava nel mondo pagano, fu
poi cacciato dal Cristianesimo, ma la sua funzione fu tenuta in vita dagli
eretici e dai liberi pensatori. Oggi la forza della ragione e del
progresso ha di nuovo vinto ogni oscurantismo e dogmatismo, cancellando
l'oppressione religiosa.
- Questo paganesimo democratico e
progressista si riveste di forma classicheggianti: il poeta riprende il
lessico aulico, la sintassi latineggiante ed i riferimenti dotti ed
eruditi
Il comune rustico (il celebratore della storia)
La poesia presenta una struttura frequente
nell'opera di Carducci:
- Una realtà presente sollecità il sogno
del poeta, che lo trasporta nel passato. Qui la fantasia evoca una scena
di vita medievale.
- Non si tratta del Medio Evo tenebroso
caro al Romanticismo ma una scena di vita civile del piccolo comune
montano, la popolazione del villaggio che si riunisce dopo la messa per
prendere decisioni fondamentali per la collettività
- Carducci vagheggia una forma di
democrazia diretta, una piccola repubblica dove ciascuno partecipa alle
decisioni e ciascuno è pronto ad assumersi i suoi compiti.
- Si scorge l'immagine di Roma, la Roma
repubblicana delle origini
- Il fine è ironico, una scena rustica di
proporzioni epiche
- Vi è una atmosfera solare in cui è
immersa tutta la scena. Nel sistema simbolico la luce rappresenta una idea
di vita sana, piena, gioiosa, intensa. Il sogno della vita solare
- Il poeta si serve per la sua
rappresentazione storica di molto materiale Kitsch ed è effettivamente un
tratto caratteristico di molte rievocazioni storiche carducciane, sia
dell'età medievale sia dell'età classica, che si muovono tra l'esotismo ed
il gusto Kitsch
Il concetto di Kitsch
Il termine è ormai entrato largamente
nell'uso. L'etimologia è nell'ipotesi della derivazione americana e tedesca ad
indicare la paccottiglia artistica destinata ad accontentare acquirenti
desiderosi di esperienze estetiche a buon mercato. Un'altra accezione del verbo
kitschen è truccare mobili per farli apparire antichi.
Il significato indica la degradazione di
motivi e forma della tradizione letteraria artistica alta in prodotti culturali
irrigiditi a stereotipi inerti.
Secondo Eco il kitsch mira alla
prefabbricazione e imposizione dell'effetto; sembra proporre contenuti profondi
ed universali, ma in realtà offre solo luoghi comuni, attraverso forme
banalizzate.
La metrica barbara
Carducci nelle odi barbare tende a
riprodurre la metrica classica. Poiché una riproduzione è impossibile , nella
lingua italiana infatti esistono sillabe lunghe o brevi. Carducci riprodusse i
metri classici come se fossero letti secondo il ritmo accentuativo moderno,
senza tener conto della quantità, cioè dell'alternanza di sillobe lunghe o
brevi. Il classicismo dell'esperienza metrica è funzionale all'esotismo
romantico di Carducci
San Martino
La poesia offre un quadretto di
paesaggio impressionistico. La poesia è rilevante perché presenta in forma
elementare il sistema simbolico centrale della visione carducciana.
- 1° strofa. Visione di natura autunnale,
che suggerisce un senso cupo di morte e di minaccia ostile da parte della
natura con connotati inquietanti ed angosciosi
- 2°- 3° Immagini confortanti, in
opposizione a quelle iniziali, l'odor dei vini e i ceppi accesi. Simboli
solari come il fuoco ed il vino. C'è un richiamo alla tematica conviviale
classica
- 4° Immagine affine a quella
dell'apertura, gli uccelli neri. Stato d'animo inconfondibilmente
romantico
Lo schema della poesia è stato definito
chiastico ABBA. Immagine negativa del poeta che cerca conforto nelle visioni di
giogia vitale à immagine mortuaria che riprende il sopravvento
- Opposizione simbolica luce- ombra
Pianto antico
Scritta nel 1871, in memoria del figlio
Dante, morto l'anno precedente.
Questo componimento presenta la tematica
dell'opposizione luce - ombra, vita - morte. Le due polarità in opposizione
sono nettamente ripartite tra le prime due strofe e le ultime due.
- Prime due strofe: immagini di luce e di
calore, con note coloristiche intense à senso della vitalità prorompente
della natura primaverile
- Ultime due strofe: motivo dell'aridità,
del freddo, del buio, dell'assenza vitale.
- Il muto orto solingo è una immagine di
morte: il giardino è muto perché non risuona più dei giochi del bambino